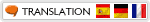Viva la sfogliatella!
Viva la sfogliatella!
 Viva la sfogliatella!
Viva la sfogliatella!
(HERMES ON LINE - 11 ottobre 2019)
Lo scorso 3 ottobre è stato celebrato il 180° anniversario dell’inaugurazione della prima ferrovia italiana, la Napoli – Portici. Contrariamente al silenzio degli anni precedenti, forse perché quest’anno la cifra tonda 180 rendeva più importante la ricorrenza, l’evento è stato ricordato in tutti i telegiornali nazionali (non solo quello regionale della Campania) ed il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato personalmente a Portici, nell’antico stabilimento borbonico di Pietrarsa, oggi Museo Nazionale Ferroviario, per celebrare degnamente l’avvenimento (vedi video in calce).
Peccato che nessuno dei politici, che si sono papariati (come fanno le papere quando camminano tronfie nel pollaio) durante la cerimonia, si sia ricordato che nel 1839 non esistevano, nell’ordine, il Regno d’Italia, la Repubblica Italiana e le Ferrovie dello Stato. A quei tempi Portici, l’opificio di Pietrarsa e Napoli appartenevano al Regno delle Due Sicilie, dove regnava Ferdinando II di Borbone. E fu proprio quel sovrano illuminato che volle la realizzazione della ferrovia, non per fare le gite con la corte, come ancora oggi recitano alcuni stupidi ignoranti, ma per realizzare le infrastrutture che ancora oggi mancano al sud, a causa delle ruberie del regnuccio Piemontese prima e del regno d’Italia e della Repubblica Italiana poi. Infatti nel progetto esecutivo della ferrovia era previsto di arrivare fino all’Adriatico e in effetti, prima dell’invasione e del genocidio dei piemontesi, la ferrovia arrivò fino a Nocera Inferiore e ad Avellino. Per chi voglia rinfrescarsi la memoria riportiamo una parte della pagina di Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Napoli-Portici:
La convenzione per la sua costruzione venne firmata il 19 giugno 1836; con essa si concedeva all'ingegnere Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie la concessione per la costruzione in quattro anni di una linea ferroviaria da Napoli a Nocera Inferiore, con un ramo per Castellammare che si sarebbe staccato all'altezza di Torre Annunziata. L'anno seguente venne costituita a Parigi la società Bayard & De Vergès, della quale facevano parte l'ingegnere, i suoi due fratelli e l'ingegnere Fortunato de Vergès, per la costruzione e la gestione della ferrovia.
Il tratto fu inaugurato il 3 ottobre del 1839 con grande solennità nel rispetto di un programma che prevedeva, dato che la stazione di Napoli al Carmine non era ancora pronta, che il viaggio avvenisse con partenza da Portici. Il primo convoglio era composto da una locomotiva a vapore di costruzione inglese Longridge, battezzata "Vesuvio", e da otto vagoni. Il re Ferdinando II pertanto si recò nella villa del Carrione al Granatello di Portici, dove era stato approntato il padiglione reale decorato all'occorrenza con accanto un altare. Verso le ore undici il re ricevette l'ingegner Bayard e la squadra di ingegneri prendendo poi posto sul convoglio inaugurale per tornare a Napoli. I vari discorsi di circostanza furono conclusi dal re Ferdinando I, il quale, in francese, espresse l'augurio di veder realizzata la ferrovia fino al mare Adriatico e a mezzogiorno ordinò la partenza davanti alle autorità .
Il primo convoglio ferroviario portava nelle vetture 48 personalità , una rappresentanza militare costituita da 60 ufficiali, 30 fanti, 30 artiglieri e 60 marinai. Nell'ultima vettura prese posto la banda della guardia reale. Il percorso venne compiuto in nove minuti e mezzo tra ali di gente stupita e festante.
Nei successivi quaranta giorni ben 85.759 passeggeri usufruirono della ferrovia. Il pittore di corte Salvatore Fergola immortalò gli avvenimenti nei suoi celebri dipinti.

L'inaugurazione della Ferrovia Napoli-Portici, di Salvatore Fergola
La linea era solo parte di un progetto più vasto: il 1º agosto 1842 veniva infatti inaugurato il tratto diramato fino a Castellammare e due anni dopo, nel 1844, la prosecuzione per Pompei, Angri, Pagani e Nocera Inferiore. Nel 1846 l'ingegner Bayard ottenne la concessione anche per il prolungamento su San Severino e Avellino.
Peccato che i signori politici e lo stesso Mattarella non si siano rinfrescati la memoria prima di parlare, dando così l’impressione che la ferrovia fosse semplicemente caduta dal cielo per permettere oggi alle FS di far bella figura. E peccato pure che, pur parlando da Pietrarsa, sede di una delle più importanti industrie del Regno delle Due Sicilie, si siano completamente dimenticati di commemorare gli operai di questa stessa fabbrica siderurgica, che furono barbaramente uccisi dai bersaglieri inviati dal governo italiano il 6 agosto 1863, mentre scioperavano per difendere il loro posto di lavoro. I bersaglieri spararono ad altezza d’uomo contro dei poveri operai, che non erano delinquenti e nemmeno briganti, pur volendo chiamare così i contadini che difendevano la loro terra. Erano soltanto degli operai a cui stava per essere sottratto il lavoro, la sussistenza, la dignità , la vita. Mi meraviglio che nessuno dei campioni di democrazia presenti alla cerimonia del 3 ottobre si sia degnato di ricordare questi martiri.
Anche qui, almeno noi lettori rinfreschiamoci la memoria (visto che i politici non l’hanno fatto), ricorrendo come sempre ad un mezzo abbastanza imparziale come Wikipedia:
(https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Pietrarsa)
Le Officine di Pietrarsa erano il maggiore stabilimento siderurgico del Regno delle Due Sicilie, ed in connessione con le Reali ferriere ed Officine di Mongiana costituivano il più importante polo industriale dello Stato. Esse erano state costituite al fine di supportare la costruzione della rete ferroviaria nazionale, che aveva avuto il suo punto di inizio nella costruzione della Ferrovia Napoli-Portici, primo tratto rotabile in Italia.
L'espansione della fabbrica continuò costantemente fino alla fine del Regno delle Due Sicilie fino ad occupare nel giugno 1860 1125 persone (850 operai stabili a cui si aggiungevano 200 operai occasionali e 75 artiglieri per il controllo dell'ordine) che la rendevano la maggiore fabbrica metalmeccanica italiana[3]. Data la sua natura di stabilimento sotto il controllo statale, Pietrarsa dipendeva completamente dalle commesse nazionali per la propria attività .
In conseguenza dell'unificazione italiana, iniziò un processo di riordino delle attività industriali a controllo statale, e nel 1861 il Ministro della Marina Luigi Federico Menabrea istituì una Commissione delle ferriere la cui minuziosa indagine analizzava lo stato di tutte le attività industriali attinenti site sul Territorio del Regno che venivano infine illustrate nella relazione conclusiva dell'inchiesta triennale pubblicata nel 1864 a cura dell'ingegnere Felice Giordano. Dal rapporto emerse che la fabbricazione di rotaie effettuata nel 1856 nello stabilimento di Pietrarsa aveva costi doppi rispetto a quelli importati dall'Inghilterra o dal Belgio, mentre più competitiva era la produzione delle locomotive, laddove i due più importanti stabilimenti del tempo (l'Ansaldo di Sampierdarena e la stessa Pietrarsa) avevano costi più o meno equivalenti o di poco superiori a quelli dell'industria estera. L'analisi minuziosa dei costi e delle attività eseguita dal Giordano quantificava dettagliatamente le retribuzioni dei lavoratori specializzati per categoria e i costi delle materie prime dei semilavorati metallici di importazione dipingendo come sostanzialmente equivalenti quelli di Ansaldo e di Pietrarsa, la cui preminenza era finita assieme al regime borbonico e al suo regime protezionistico. Il maggior costo di produzione dei prodotti siderurgici prodotti nel territorio del Regno scaturiva dalla loro provenienza estera nonché dall'alto costo dell'approvvigionamento dell'indispensabile carbone inglese.
Nell'ambito del suddetto processo di riordino, una relazione dell'ingegnere Grandis dipinse negativamente l'attività e la redditività dell'opificio consigliandone addirittura la vendita o la demolizione. Conseguentemente, fu effettuata una scelta di razionalizzazione del settore siderurgico e produttivo in favore dell'industria settentrionale. Il 10 gennaio 1863 lo stabilimento di Pietrarsa con quanto conteneva fu concesso in affitto, per 30 anni alla somma di 45.000 lire dell'epoca, dal Ministro delle Finanze del governo Minghetti alla ditta costituita da Iacopo Bozza; ciò portò alla riduzione progressiva dei posti di lavoro.
In conseguenza di quanto sopra, lo stabilimento fu interessato da una serie successiva di scioperi da parte degli operai, che si protrassero fino al 23 giugno 1863. In questa data, Bozza promise il reintegro degli operai licenziati, ma al prezzo di dimezzare lo stipendio a tutti i lavoratori. I 458 operai restanti tuttavia non ricevettero in tempo lo stipendio ed il 6 agosto 1863 entrarono nuovamente in sciopero con maggior decisione. Alle due del pomeriggio il capo contabile Zimmermann contattò il posto di polizia di Portici, chiedendo l'invio di sei agenti per contenere gli operai. La forza pubblica si rivelò tuttavia insufficiente, e fu inviato un contingente di bersaglieri al comando di Nicola Amore, poi divenuto sindaco di Napoli. Gli operai aprirono i cancelli per parlamentare, ma i militari caricarono, non fermandosi neanche alla fuga dei lavoratori.
Il risultato della carica fu di 4 morti accertati e 17 feriti. I morti accertati sul posto furono Luigi Fabbricini ed Aniello Marino, mentre Domenico Del Grosso ed Aniello Olivieri morirono all'Ospedale dei Pellegrini di Napoli. Rimasero invece gravemente feriti e portati anch'essi all'Ospedale dei Pellegrini gli operai Aniello de Luca, Domenico Citale, Mariano Castiglione, Salvatore Calamagni, Antonio Coppola. Meno gravemente feriti e curatisi in famiglia gli operai Alfonso Miranda, Raffaele Pellecchia, Giuseppe Chiariello, Carlo Imparato, Tommaso Cocozza, Giovanni Quatonno, Giuseppe Calibè, Leopoldo Aldi, Francesco Ottaiano, Pasquale de Gaetano, Vincenzo Simonetti, Pasquale Porzio. Nella sua relazione al Prefetto, Nicola Amore parlò poi di fatali e irresistibili circostanze.
Sappiamo purtroppo che la cosiddetta questione meridionale, nata dopo le ruberie ed il genocidio del Sud seguiti all’unità d’Italia, non sarà mai risolta finché saremo rappresentati da politici da operetta, come sono quelli che oggi ci governano e come furono purtroppo anche in passato.
E senza voler toccare i massimi sistemi, questo atteggiamento di sufficienza, per non dire di disprezzo, nei riguardi del Sud dà la stura anche a sbeffeggiamenti squallidi e volgari come quello della pubblicità del Buondì Motta (vedi video in calce), che associa la città di Napoli alla musica neomelodica ed esorta il pubblico a fare una colazione “a prova di deficienza artificiale”, mangiando appunto il Buondì.
Ma come si permettono questi cafoni ignoranti? Non sanno che Napoli è stata ed è tuttora una capitale a livello europeo, culla di arte, di cultura, di bellezza, di gioia di vivere e, in una parola, di civiltà ?
Proprio il prodotto, che essi vorrebbero pubblicizzare con quello squallido filmato, è un esempio marchiano di deficienza artificiale. Noi – grazie al cielo – non abbiamo bisogno di quella robaccia. Che la mangino a Torino o a Milano. Noi preferiamo la sfogliatella, riccia o frolla, ma sempre calda e fragrante, come una bella donna. Altro che deficienza artificiale!